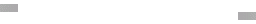Ogni opera di Ganau è come il fotogramma di una pellicola che, scorrendo davanti ai nostri occhi, sorprende per la familiarità delle scene, delle figure e dei gesti che riproduce. È un’arte scenograficamente evocativa che gioca con i codici comunicativi della contemporaneità (cinema, musica, linguaggio pubblicitario), nobilita l’ordinario (si pensi all’immagine del tatuatore all’opera), racconta il disordine metropolitano e si fa sempre più determinata e disinibita di fronte alla scelta del colore, impiegando meno il bianco e nero delle origini, senza però rinunciarvi del tutto. Con la sola eccezione dell’autoritratto dell’artista che va tautologicamente a con-fondersi con una delle sue opere, è raro che l’arte di Ganau giochi con le parole. Ne fa, sì, uso, ma con disciplina e circospezione, consapevole del peso che le parole possono avere quando si offrono come il commento testuale di un’immagine.
È un’arte didascalica, quella di Ganau, nel duplice senso di questo termine. Lo è, innanzitutto, perché la parola viene incorporata, quasi inghiottita, nell’opera che se ne serve e alimenta. Si tratta poi di un’arte eloquente, che parla e interpella, che dice e interroga, perché ogni immagine equivale a un’interrogazione. L’autore vi ha sigillato dentro la sua risposta, ma questa non vuole essere vincolante ed esclusiva. Una risposta deve essere però data e la domanda non può essere elusa. In fin dei conti, è questo che l’artista chiede, chiamando in causa l’osservatore, perché, a suo modo, completi l’opera, interpreti la sua parte, indossi e getti la maschera. “Come ognuno di noi”. Niente di più. Niente di meno.
Nel lavoro di Gavino Ganau appropriazione e montaggio sono metodo costruttivo e decostruttivo insieme. In un’epoca “immaginaria” come la nostra, la rappresentazione tenta di sostituirsi alla realtà e l’apparenza si finge neutrale, si vende come affidabile. Dietro a fotografie che si mostrano come inconfutabili e brevi slogan urlati e ripetuti, il potere delle immagini può farsi utile alla costruzione di immagini di potere. Non è un caso che il politico e il religioso abbiano da sempre guardato con grande interesse e preoccupazione all’effetto persuasivo di un manifesto, al culto dell’icona, alla produzione artistica del momento.
Questa nuova serie pittorica abbandona il privilegio del bianco e del nero delle produzioni precedenti , per aprirsi ai passaggi intermedi e si accosta all’illustrazione, più vicina al mondo della pubblicità e dell’editoria, che Ganau omaggia di riferimenti, citazioni, saccheggi.
L’artista decide qui di prendere posizione dalla parte dei soggetti esposti alle controversie della propaganda, accoglie la sfida contemporanea posta al ruolo politico dell’arte e ne celebra i momenti di massima potenza critica.
Prendere posizione significa però interrogare la stessa postura delle opere in mostra. A new marketable series solleva la soglia d’attenzione sul fascino dell’estetica al servizio del marketing pubblicitario e politico. Gioca a carte scoperte. Dichiara senza riserve il valore commerciabile dell’oggetto-opera d’arte che, liberato dalla sua aura mistica, può farsi anche scambio, circolazione, consumo, guadagno. Ma, proprio perché radicalmente critico, quasi autoimmune, non firma una resa incondizionata al mercato.
La sua pittura, in bianco e nero, ricca di elementi, nasce dalle collisioni, dall’incontro tra inquietudine, malinconia e poesia con le immagini delle riviste patinate, dei film di culto e delle star musicali.
Ma la sua priorità consiste nell’elaborare le tele come se fossero progetti, di far gravitare attorno ad
essi l’ipotesi di un perenne nomadismo mediale che esplora le profondità dell’anima. Tutto questo compresso nel breve volgere di opere composte da tre pezzi, o quattro, come i due Only the landscape is changed del 2001, frammenti di un discorso che coinvolge luoghi e situazioni distinte. Si tratta di opere in cui ogni singolo dettaglio rimanda all’immenso repertorio musicale cinematografico e letterario che ha accompagnato la generazione di chi oggi è intorno ai trent’anni. Una sorta di galleria dei generi in movimento, ambientazione perfetta per sintesi autobiografiche, dove la pittura procede
per impercettibili spostamenti e l’ipnosi della musica techno diventa un tappeto sonoro insieme etereo ed avvolgente. Ma soprattutto capace di mescolare sentimenti personali e immagini stereotipate, arrivando a scavalcare barriere geografiche talvolta ingombranti. Da Skin a Sophieisdead sino a Wish you were here, tutti lavori recenti, il metodo di lavoro di Gavino Ganau arriva ai margini dell’orchestrazione, come se la contraddizione tra i fermenti delle tribù contemporanee e la sua vita personale si incontrassero su un unico piano narrativo.
Sembra quasi che, nelle sue opere, i ritmi metropolitani siano un pretesto, un tramite per raccontare un’evoluzione interiore scandita dai mass media, in fuga dal territorio in cui nascono per raggiungere mete indefinite.
Ma per la ricostruzione di un fatto realmente accaduto bisogna guardare Sophieisdead (Yuki), che mette in scena l’idea stessa di mixaggio secondo l’artista. Non necessariamente intervento sequenziale su attimi reali, ma ricostruzione totale degli avvenimenti, con il compito di trasferire sentimenti privati affidato a immagini altrui.
Il risultato è una catalogazione di dischi, libri e film amati che quotidianamente vengono prima controllati e in seguito selezionati, poi scelti e infine dipinti.
Una metodologia che sembra appartenere più ad un rito che ad un attimo vissuto da incastrare con un altro. Un’opera che cerca di esplorare in profondità la natura delle immagini provando a scoprire le connessioni che esistono tra i ritmi dello star system e le pulsioni della cultura giovanile più estrema.
L’unico denominatore comune è l’energia che arriva dal meticoloso campionamento,un lavoro che si può fare ovunque e che volontariamente si lascia alle spalle il rapporto con l’iconografia della terra d’origine.
Partendo dalla natura fotografica del bianconero, Ganau insiste sull’energia esplosiva di ogni immagine.
Ci presenta gli spasmi della vita borderline.
E lo fa con primi piani da cinema, con frasi che si imprimono sull’immagine, con angoli particolari dell’inquadratura.
Con Ganau il pennello indossa un contrasto mediatico tra la dominante scura e le zone di bianco.
Nero, d’altronde, è il clima dei suoi frame, ipnotizzati sul punto di un’esplosione endogena. Bianca, invece, appare la dilatazione dello sguardo, la visione limpida sopra il reale. L’artista cattura inquadrature dai principali mezzi mediatici, televisione e riviste in testa. Sceglie storie abbaglianti che si comprimono nel dettaglio scenico. Come se un punto catartico raccogliesse l’energia di una storia dentro pochi secondi di dissolvenza. La pittura di Ganau è raffinata, intelligente, acuta.
Rielabora l’essenzialità del bianconero fotografico e le astuzie formali di certo cinema. Parte da elementi esistenti per esaltarli attraverso la sublimazione manuale. Ogni frame identifica una zona adrenalinica , quel punto dove le cose accadono in modo pieno e assoluto. Da un volto di ragazza all’icona nera Skin, da uno scenario techno ai lampi nel paesaggio periferico, lo stupore (il nostro) e la forza (del quadro) legano il racconto di Ganau alle emozioni, alla durata di una nuova bellezza, ai sentimenti delle molte nature ambigue.
…Sentiamo strani rumori nell’aria, le azioni dei protagonisti si destano nell’evenienza del plausibile allarme…
La volontà abrasiva dell’autore è in grado di far affiorare in superficie la grana sottostante la realtà immediata e meno interessante di milioni di immagini per concentrarsi sugli istanti significativi. I suoi paesaggi come anche i ritratti ripercorrono la tradizione, peraltro venerata, di Hopper e raccontano l’isolamento attraverso una pittura elettronica, fatta di acrilici ben dosati, di sfumature intermedie del giorno e della notte, di bianchi e neri molto complici e di infiniti grigi dentro cui sembra trovare una ricerca quasi cromatica di colori per loro natura poco solari. Dopo gli studi lontani dall’arte, a 24 anni Gavino Ganau scopre la volontà di manifestare un punto di vista orgoglioso, di restituire fragore alle infinite situazioni sospese che scorrono ogni giorno di fronte ai suoi occhi.
Attraverso una parsimoniosa scansione dello schermo si genera alfine una salutare collisione creativa, laddove è proprio l’abnorme moltiplicazione delle informazioni tecno-visuali a far scattare una nutritiva convivenza con queste. La sua capacità di confezionamento ricopre di una lucida patina ciò che passa all’interno del video e nella consapevolezza delle tonnellate di pixel assunti ogni giorno con distrazione, innesta un deciso rifiuto all’omologazione imposta ovunque.
Nei lavori ultimi Ganau avanza un passo in più nella propria ricerca figurativa e opera una sintesi poetica tra il fermo immagine da video e la sua trascrizione in segni sintetici ed evanescenti: la versione che ne deriva focalizza l’attenzione su volti che non guardano ma chiedono di essere guardati mentre la forma si disperde nella nebulosità di un’immagine persa…
Chi conosce l’opera di Ganau e ne segue da tempo gli sviluppi, nota facilmente come la tecnica non sia affatto cambiata, come anzi si sia affinata, dando la chiara impressione di un artista che è sempre più a suo agio con la sua arte. Il messaggio è frontale. Le didascalie, che valgono come concetti, non hanno niente di intellettualistico. L’inglese, lingua madre del movimento estetico al quale bisognerebbe ascrivere Ganau, libera talvolta il campo all’italiano. Anche il linguaggio diventa così una scorciatoia, semplificando l’approccio all’opera. La ricerca – in questo modo Ganau concepisce il suo ruolo di artista – inizia a procedere per cicli, per temi seriali. Il “movimento”, per fare il verso ad un noto film di Wenders, è sempre più meno “falso”, e l’immagine è sempre più immagine.
L’ossessione claustrofobica dell’arte vive anche nelle opere di Ganau, artista metropolitano che guarda il mondo da una prospettiva geograficamente periferica, costretto, suo malgrado, a scontrarsi con quanti (e non sono purtroppo pochi) pensano che l’arte abbia sempre un vincolo naturale, un cordone ombelicale che non deve mai spezzare con la tradizione, il locale, la provenienza. Il dilemma, se tale può dirsi, sta tutto nella contrapposizione non poi così gratuita tra due modi di pensare: uno locale, l’altro globale e planetario. Un dilemma forse sciocco e facile da risolvere se si crede che basterebbe pensare, semplicemente pensare e non fingere di pensare. Sia etnico, sia global. Che nessuno chieda però a Gavino Ganau di tradire sé stesso, vestendo i panni di un improbabile Biasi postmoderno. Sarebbe una forzatura, una tortura, un’infida opera di scimmiottamento di qualcosa che non gli appartiene. Quella che emerge in opere come “Endless land” (un ciclo figurativo destinato a diventare uno dei filoni principali e più duraturi) è una visione speculare della globalità, assunta e registrata a partire da un dato punto di vista: quello di chi scandaglia il mondo con un periscopio la cui base è a Tempio Pausania, semplicemente per ragioni di opportunità. Jerin, New York, Kandahara non sono, d’altronde, così lontane, per chi racconta il mondo attraverso lo smontaggio di videoclip, fotogrammi e spot pubblicitari. E fare ciò da Tempio, in una delle poche località montane della mediterranea Sardegna, non è cosa così stravagante.
Ciò fa sì che l’arte di Ganau sia paragonabile ad un’opera di sciamanica ricomposizione del mondo ridotto in frammenti. Un mondo riconvertito ai suoi colori originari, il bianco e il nero, per una non dichiarata e forse non confessabile opera di redenzione minimalistica della complessità. Anche Ganau, non meno di molti altri suoi colleghi, crede che destino dell’arte sia quello di salvare il mondo, perché se l’arte ha una sua ragion d’essere alla quale potersi ancòra affidare in tempi di magra, questa può essere solo la pretesa, assurda, impossibile ed esaltante, che, tutto sommato, ci sia ancòra un mondo da salvare. Lasciamoci, pertanto, guardare (come recita, a suo modo, il titolo di una recente personale) dalle diafane valchirie e dalle bellezze esangui della galleria femminile di Ganau. Opere che hanno l’onestà di considerare il mondo per quello che in realtà è, una natura morta non più imbellettabile che reclama pietà e briciole di redenzione.
Per Lara però ho fatto da sempre un’eccezione. Per lei ho trasformato in gamemachine il mio serissimo e inappuntabile Apple, con lei sono stato sveglio notti intere e interi week-end, sempre con lei ho visitato bassifondi e locali equivoci (mai una cena di gala!) di Londra, Venezia, Praga, Parigi. Al suo fianco prima ho combattuto scheletri, mummie, gangster e addirittura un intero monastero di monaci tibetani molto, molto incazzati, poi ho affrontato – io aracnofobico da manuale – un numero imprecisato di gigantesche e velenosissime vedove nere. Insomma, Lara potrebbe portarmi ovunque, e anche se non l’ho mai vista sorridere, non l’ho mai vista elegante, non l’ho mai conosciuta dolce e carina, so che lei è la ragazza dei miei sogni, lei è la Marylin Monroe del terzo millennio. D’accordo, preferisce Bang Bang a Bye Bye Baby, la trovi più facilmente nelle cantine e nei cunicoli piuttosto che sulle grate ventose della metropolitana, se la fai arrabbiare potrebbe sempre tirarti una revolverata alla schiena ma, si sa, la donna perfetta non esiste.
Lara è, ovviamente, Lara Croft, alias Tomb Raider, ovvero la versione femminile e tecnologica dell’Indiana Jones cinematografico. Lara è la donna bellissima e pericolosa, la Mantide, la femmina bella e fatale, armata e a volte cattiva, che molti uomini sognano d’incontrare ma, per fortuna loro, hanno poi la fortuna di non farlo. Lara, come in certi quadri di Gavino Ganau, è amore e violenza, baci e pallottole, carezze e pugnali. Lara è la dark lady del secolo scorso rivista e corretta oggi alla luce dell’immaginario contemporaneo: ancora calze a rete certo, ma in abbinamento a un armamentario da guerra in iraq e a una pietà oramai più che defunta. Lara è la personificazione perfetta di un tipo di sensualità estremamente seducente: la sensualità aggressiva, sicura di sé, dominante, che gran parte degli uomini, forse proprio quelli apparentemente più maschilisti, inconfessabilmente adorano. Vanno benissimo le donne di Nobuyoshi Araki, legate, imbavagliate e sottomesse, sono straordinarie quelle di Richard Kern, esposte e svelate, paiono davvero fantastiche e da sogno porno quelle disponibilissime, senza pudori e senza difese di Terry Richardson, ma vuoi mettere con il potere seduttivo dell’Uma Thurman di Quenti Tarantino in Kill Bill? Non c’è confronto, sulla sensualità non c’è proprio partita. Si rischia grosso, ma la posta in palio è di ben altro spessore.
L’incontro tra due artisti ha sempre l’alone del mistero. La quiete prima della tempesta e, insieme, il fremito della seduzione. Potrebbe accadere tutto. O anche niente… e il fascino non ne risulterebbe scalfitto. L’incontro tra Francesca Randi e Gavino Ganau ha il tocco lieve del minuetto. Il loro studiarsi guardinghi e ammirarsi da lontano si è presto risolto in un un lungo, lento corteggiamento tra pittura e fotografia… una reciproca seduzione che travalica limiti tecnici o didascalici per sdradicare ogni definizione e perdersi nell’onirico. Un percorso fatto di incastri, di sovrapposizioni e citazioni. Un cammino a zig-zag che ondeggia tra opposti. Entra in gioco ogni possibile estremo: maschile/femminile; nord/sud; colore/bianco&nero; rock/jazz. Il racconto è infinito. Del resto, nell’incontro artistico, come nell’amore, avvertiamo confusamente che ci stiamo concedendo a qualcosa che ci trasformerà, che modificherà chi crediamo o pretendiamo di essere. Per questo c’è creazione autentica solo in questo scarto, nel salto che da un io solitario conduce ad un noi creativo, ad un dialogo a cui si accede solo affidandosi all’altro, lasciandosi accogliere da un intricato sistema di relazioni e di risonanze, un sistema dove ogni elemento agisce sull’altro, a tal punto che questo percorso ha senso solo se valutato nel suo insieme. Ad osservare questo dialogo visivo, la prima sensazione è lo shock della discontinuità. La biplanarità della superifice diventa parte attiva dell’azione in cui occhio e mondo tentano un contatto attraverso l’immagine. Immagine che, a sua volta; parte dalla dualità come possibilità abitativa-occupativa di uno spazio vuoto, inteso come spazio espositivo, certo, ma ancora di più come possibilità esistenziale. Abitare l’esistere. Occupare il contemporaneo. Immagine vissuta, quindi, come segno inatteso, che svela qualcosa che non conosciamo ancora, possibilità che appena intuiamo. Il confronto tra questi due artisti – due personalità distanti eppure complementari – il loro incontro e mescolamento ci coglie impreparati come un flusso suadente che riveste la vita con il desiderio delle cose e il loro mistero; un’onda che fa convivere il dissimile, l’estraneo, il perturbante, l’onirico. L’immagine è dunque “solo” una ben camuffata “esca per lo sguardo” che seduce l’osservatore, lo avvolge fino a farlo diventare parte integrante di questi duetti, fino a recitare il ruolo di terzo protagonista di questa commedia che è la conoscenza. Perchè, come dice Murakami Haruki in 1Q84, «ognuno di noi vive per dare una spiegazione a quel qualcosa che le immagini tentano di insegnare».